
|
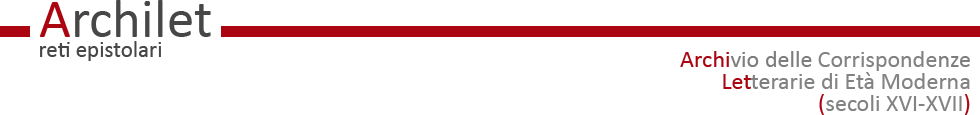 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Mittente |
[Malvezzi] [Virgilio] |
Destinatario |
[de Haro] [Luis] |
| Data |
1652 |
Tipo data |
congetturale |
| Luogo di partenza |
[Castel Guelfo] |
Luogo di arrivo |
|
| Incipit |
La presa di Torino e di Casale |
| Contenuto e note |
In questa lettera di Malvezzi [scritta sulla scia dell’effimera ripresa della Spagna alla fine del 1652, e il cui tono lascia credere che essa fosse pensata per una fruizione pubblica e non destinata quale personale congratulazione a don Luis de Haro, ‘privato’ di Filippo IV di Spagna, o al re in persona] vengono entusiasticamente ricordate le vittorie spagnole come la presa di Torino e quella di Casale [ottobre 1652], la conquista di Napoli, la riconquista di Porto Longone [luglio 1650] e delle due piazzeforti delle Fiandre, Grevelingen e Doncherchen [Dunkerque, 1652], e infine la conquista di Barcellona [ottobre 1652]. Grande dunque il merito del re di Spagna che “ha acquistato quello che i suoi antepassati ereditarono”. Seguono altre lodi del re Filippo IV che, mostratosi più lungimirante e deciso dei suoi predecessori come Carlo V, ha dato prova di forza, magnanimità (per questo, tra l’altro, è stato chiamato Grande) e clemenza, soprattutto con i catalani sui quali gli altri sovrani spagnoli non avevano saputo dominare stabilmente. Carlo V, ad esempio, ha vinto gli uomini “ma ebbe in suo favore gl’uomini e la fortuna, e quando questa se gli mostrò contraria, se non perdette, si perdette; abbassò le vele, ed approdò al porto”. Il successo di Filippo IV invece è stato ridimensionato da una “pace infame” [quella di Vestfalia (1648) che vide l'indipendenza delle Province Unite e l’accendersi di un nuovo, lungo conflitto con la Francia]. Altre paci simili a quella, “fatte con tanto scapito di riputazione”, avvennero al tempo dei sovrani francesi Luigi XI, Luigi XII, Francesco II, Enrico III. E il Malvezzi cita ancora la pace di Vervins [1598, avvenuta al tempo di Enrico IV di Francia e di Filippo II di Spagna il quale rinunciò allora ad ogni velleità imperialistica] e la pace di Monzón [stipulata nel 1626 tra Francia e Spagna sulla questione della Valtellina] e quindi fa un’allusione al [conte-duca Gaspar de Guzmán de Olivares] ‘privato’ [di Filippo IV] considerando “quanto può apportare al suo signore, tanto d’utile quanto di danno, il fortunato valore e lagrimabile disdetta d’un privato”. Richiama poi, il Malvezzi, la profonda religiosità del sovrano regnante spagnolo affermando che si riconosce Dio solo laddove si riconosce Sua Maestà per re: quello stesso Dio che ha voluto mettere alla prova il sovrano facendo insorgere contro di lui “quasi tutto il mondo; guerre interne, esterne, in Italia, in Ispagna, in Alemagna, in Fiandra, nell’Indie Orientali, Occidentali, ne’ mari oceani, mediterranei, facendoli contrarii tutti gli eretici, gran parte de’ cattolici, i rebelli, gl’emuli, i parenti, gl’amici, i collegati, se non la moglie il cognato, se non i figli i sudditi” affinché ne apparisse quanto veramente questo sovrano fosse devoto a Dio. Ecco perché “si sono veduti tanti disastri, e perché dopo d’essi sucedono tante felicità, e sempre verranno maggiori”. [Questa lettera del Malvezzi a don Luis de Haro è citata dal Pallavicino in una sua lettera al Malvezzi del 29 dicembre 1652: cfr. n. 24 Carminati]. |
| Fonte o bibliografia |
Clizia Carminati, Il carteggio tra Virgilio Malvezzi e Sforza Pallavicino, “Studi secenteschi”, XLI, 2000, pp. 426-429 (Appendice) |
| Compilatore |
Giulietti Renato |

|
  vai al documento vai al documento
|

|

|

|
 Torna all’elenco dei risultati Torna all’elenco dei risultati
|

|

|

|
|
|

|
|
|
|
|
|